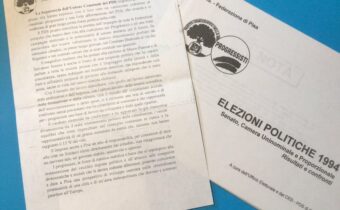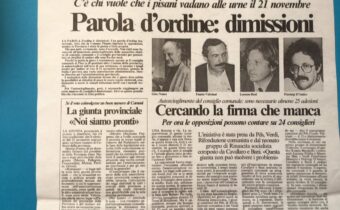L’ultima discussione parlamentare sull’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”) è avvenuta nella XVII legislatura con l’approvazione alla Camera dei Deputati del testo di una proposta di legge l’8 giugno del 2016. Proposta che poi non ha avuto seguito al Senato. Credo che sia giusto e necessario non abbandonare ma semmai riprendere quella discussione, soprattutto alla luce dei segnali di ulteriore indebolimento del rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni messo in evidenza da crescenti fenomeni di allontanamento e di rigetto verso la politica. Fenomeni che certamente non rafforzano la coesione nazionale. Penso che non sia possibile una democrazia realmente rappresentativa senza i partiti, perché senza soggetti collettivi si finisce nel “governo autarchico” più o meno autoritario che sia. Ma per ricostruire attenzione e credibilità verso i partiti la prima cosa da fare è rendere praticabile la partecipazione attraverso regole che garantiscano il processo democratico di adesione, di responsabilità e di militanza, in un quadro di piena trasparenza del funzionamento, dell’attività e del finanziamento delle forze politiche.
Mi è stato chiesto un contributo di valutazione su quel passaggio in quanto una delle proposte di legge sulla materia mi vedeva come primo firmatario. Il numero delle proposte di legge depositate sulle quali iniziò il lavoro della Prima Commissione arrivò a ventuno testi, che comprendevano aspetti e obbiettivi assai diversi fra loro; da quelli più strettamente connessi al funzionamento dei partiti a quelli della istituzionalizzazione delle elezioni primarie, alla disciplina di selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali, fino alla promozione dell’equilibrio di genere. Il confronto in Prima Commissione portò subito a una delimitazione delle questioni restringendo il campo alla disciplina sui partiti strettamente riferita all’articolo 49, e in particolare sulla questione del “metodo democratico” con cui “i cittadini si associano liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale”. In sostanza sulla regolazione della vita democratica interna e sulla sua piena trasparenza. Questioni che chiedevano un impegno chiaro e convinto sul piano della definizione di alcuni essenziali indirizzi dal punto di vista statutario e sul riconoscimento della personalità giuridica dei partiti, oltre alla volontà di rendere più forti e incisive le prescrizioni sul piano della trasparenza dei finanziamenti. Furono tolti subito dalla discussione i temi connessi alla selezione delle candidature e sui meccanismi di finanziamento delle fondazioni. Va ricordato che all’epoca era in campo la proposta di riforma della legge elettorale cosiddetta Italicum, poi bocciata dalla Corte Costituzionale. Una normativa che certamente non andava nella direzione di valorizzare il potere di scelta degli elettori sui candidati, ma anzi aumentava lo spazio decisionale dei capi e dei vertici dei partiti sottraendolo ai cittadini, e anche agli iscritti o associati dei partiti e dei movimenti. Limite, questo, che in realtà è rimasto in misura ampia anche nell’attuale legge elettorale. In realtà per dare una risposta efficace all’obbiettivo della legge sui partiti, che era quello di contrastare il processo di distacco e di sfiducia fra i cittadini, i partiti e le istituzioni che si andava affermando nel Paese, sarebbe stato fondamentale affrontare anche il nodo delle procedure per la selezione delle candidature. Tuttavia le condizioni politiche per una normativa avanzata e coraggiosa non ci furono, nella minoranza così come nella maggioranza, e nel PD in particolare. Comunque fin da subito il M5S si mise di traverso sull’idea di dare agli statuti un valore importante sul piano della trasparenza della vita democratica, contestando il principio della regolamentazione. Ovvero della utilità della legge. Anzi, vedevano nel ragionamento sul rilancio della partecipazione dei cittadini alla vita politica e nei partiti un pericolo, una insidia rispetto alle modalità organizzative con cui il loro movimento si era affermato. Modalità, come sappiamo, tutt’altro che trasparenti e democratiche, del tutto avverse alla eventualità che qualcuno potesse “mettere il becco” dentro ad una struttura governata da una piattaforma opaca come quella gestita da Casaleggio. Una ostilità comune a quella di Forza Italia, che respinse l’idea della regolamentazione in quanto “i partiti devono essere organizzazioni libere senza essere soggette a nessun tipo di camicia di forza”, come sostenne l’on. Sisto in tutto il confronto. In verità la contrapposizione iniziale del M5S trovò un aggancio in una forzatura evidente presente nella proposta di legge “ufficiale” del PD, che aveva come primo firmatario il vice segretario Lorenzo Guerini, nella quale, in sostanza, si subordinava la possibilità di partecipare alle elezioni alla piena adesione a quelle regole. Ovvero alla scelta di essere un partito. Questa norma, difficile da accettare per un movimento che rifiutava ogni somiglianza con i partiti, che fu di fatto demolita dai pareri dei giuristi nell’ambito delle audizioni in commissione, permise tuttavia al M5S di gridare al vittimismo e di svicolare da un serrato confronto sul rapporto stretto fra democraticità e trasparenza per un soggetto politico che svolge una funzione pubblica, che fa parte comunque dell’ordinamento istituzionale. Infatti l’obbiettivo principale della legge era quello di indicare precise disposizioni per connettere e rendere verificabili principi più volte enunciati ma quasi mai perseguiti. Questo nesso sfuggì o fu sottovalutato anche dal gruppo di Sinistra Italiana che, pur in un ragionamento serio sulla crisi della democrazia e dei partiti, scelse un posizionamento politico di distinzione. Nel caso della proposta di legge che avevamo presentato io e Gianni Cuperlo insieme ad altri trenta deputati del PD il punto centrale stava proprio nell’idea, attraverso la conoscenza e la piena trasparenza dei processi decisionali dei partiti, di mettere nelle mani degli iscritti, degli elettori e di tutti i cittadini gli strumenti per far valere le proprie opinioni, a cominciare dal diritto all’informazione e alla conoscenza dei processi decisionali, e quindi di poter esercitare liberamente la propria responsabilità, senza delegarla o scaricarla su altri; con la conseguenza oggettiva di spingere i partiti verso forme organizzative improntate ad una larga ed effettiva partecipazione, anche attraverso l’ampia e verificabile utilizzazione del web. In questo senso il punto di partenza della nostra proposta, e anche di altre, era il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti e conseguentemente l’istituzione del registro nazionale dei partiti. Questa scelta avrebbe prodotto un quadro nuovo e diverso sul piano della responsabilità, sia nell’ambito dei gruppi dirigenti che in quello degli iscritti o dei simpatizzanti. Ma su questo punto si manifestò una larga contrarietà con la motivazione che ciò avrebbe incentivato i ricorsi alla magistratura, come se interventi di questo genere non siano possibili già adesso in virtù di lotte interne spesso assai poco trasparenti. Altro sarebbe però un segnale chiaro e un discorso esplicito rivolto ai cittadini per dire loro che hanno tutto il diritto di pretendere coerenza e rigore nell’agire democratico dei partiti, a cominciare dal rispetto degli Statuti che questi liberamente si danno con la condivisione dei propri iscritti.
Alla fine nel confronto in Prima Commissione prese corpo il testo unificato portato in Aula da Matteo Richetti, come relatore, il 26 maggio del 2016, con una evidente attenuazione della valenza innovativa delle norme. In particolare si rinunciava alla personalità giuridica e si rimaneva fermi alle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute. Tanto che nel voto finale ci fu l’astensione sia il M5S che Forza Italia. Era evidente che senza il riconoscimento della personalità giuridica e senza una puntuale e incisiva articolazione dei doveri di trasparenza in merito alla democrazia interna, il dispositivo diventava meno impegnativo per i partiti e i loro gruppi dirigenti. E ciò si capisce ancora meglio oggi, in questa fase, in cui tocchiamo con mano ogni giorno l’evoluzione di un sistema politico sempre più personalizzato e guidato da piattaforme o luoghi di decisione assai difficili da individuare. Provare a citare occasioni o momenti della vita politica in cui si possa riscontrare qualcosa che ha attinenza con la partecipazione e il metodo democratico è diventato un esercizio impossibile. Comunque, se quella legge, anche se timida, fosse stata approvata dal Senato forse avrebbe dato un impulso a discutere di questi problemi, a rendere certamente più trasparente il percorso che ha ha portato all’attuale assetto politico, che vede insieme al Governo due forze che in campagna elettorale stavano agli opposti, e forse anche ad attenuare la spinta anti politica che alimenta un pericoloso logoramento delle istituzioni democratiche. Ma la questione è capire perché, soprattutto nelle forze di centro sinistra, si è rinunciato ad affrontare questo tema, quello della battaglia per il rilancio della credibilità dei partiti, e della loro funzione nazionale, in quanto organizzatori della partecipazione dei cittadini. Perché si è accettata l’idea della politica fatta soprattutto di leaderismo, di staff del leader e di comunicazione. Perché si è affermata la pratica della politica come totale delega e limitazione della responsabilità al momento del voto, talvolta ignorando il pesante incremento dell’astensionismo, peraltro esaltando l’assai discutibile partecipazione delle primarie aperte a tutti. La legge poteva essere l’opportunità per spingere i partiti verso l’autoriforma. Si poteva se si accettava l’idea di mettere i cittadini nella condizione di poter “mettere bocca” sulle vicende interne dei partiti, di affidare a loro questa responsabilità di essere garanti della vita democratica e della trasparenza dei partiti, senza per questo mettere in discussione l’autonomia politica e organizzativa di nessun soggetto politico. Certo, la discussione attorno al tema dell’attuazione dell’articolo 49 ha una storia lunga e complicata, e presenta aspetti giuridici delicati che consigliano cautela, soprattutto sul piano della salvaguardia della libera iniziativa dei cittadini come dei partiti. Gli elementi di questa preoccupazione li abbiamo ascoltati più volte, in particolare nelle audizioni dei costituzionalisti, ed è giusto inquadrare il dibattito nell’ambito dei valori e degli indirizzi della Carta Costituzionale e della democrazia rappresentativa.
Tuttavia non possiamo ignorare il cambiamento profondo che nel corso degli ultimi decenni ha modificato il sistema politico, dalla fine dei partiti di massa all’espansione dell’influenza e del condizionamento del sistema mediatico fino all’avvento del web. I luoghi e gli strumenti della formazione delle idee e del senso comune sono mutati e la funzione dei partiti nella percezione dell’opinione pubblica è diventata negativa, vista essenzialmente come espressione degli interessi e dei privilegi di una casta. Anche perché la politica, dopo tangentopoli, non ha dato risposte efficaci sul piano del rinnovamento del sistema. Forse era quello il momento giusto per mettere all’ordine del giorno la questione dell’Articolo 49, magari insieme alla discussione sul finanziamento pubblico dei partiti. Invece ci si è trovati, anni dopo, a decidere l’abolizione del finanziamento pubblico sull’onda di una spinta antipartitica, con il risultato che anziché arginare il qualunquismo del “i politici sono tutti uguali”, “tutti i partiti rubano”, lo ha legittimato. Eppure gli ammonimenti sui rischi di logoramento e di indebolimento della democrazia c’erano stati. Cito, ad esempio, il volume di Roberto Ruffilli, intitolato “Il cittadino come arbitro” e pubblicato nel 1988, poco prima del suo assassinio, in cui poneva l’esigenza di un ripensamento, sul piano della trasparenza e della responsabilità, del rapporto fra i cittadini e lo Stato e tra i cittadini e il sistema politico. Scriveva che “una democrazia nella quale il cittadino sente di non poter sostanzialmente incidere sul sistema politico è una democrazia debole; e lo è ancora di più quando a questo si accompagni la convinzione che il sistema politico è sostanzialmente irresponsabile e non consente la trasparenza dei procedimenti decisionali. Quando ciò accade, il sistema si chiude ed alla fine si distacca dalla società civile creando pericolosamente, al di là delle sue caratteristiche formali, ragioni di crisi della democrazia.” E purtroppo è proprio ciò che è avvenuto e che ha spalancato la strada ai processi di personalizzazione della politica, alle logiche plebiscitarie, alle pratiche decisioniste e alla demolizione della intermediazione politica e sociale. La cultura politica diffusa si è imbevuta di queste idee ed è diventato naturale dire “basta con i partiti”, oppure “ormai hanno fatto il loro tempo”. In un certo senso tutto questo è testimoniato non solo da una serie di filoni del dibattito politico mediatico, ma anche da una attenta lettura dei rapporti del CENSIS, che nel 2015 metteva in evidenza, nella sua fotografia del paesaggio sociale italiano, il “trionfo assoluto dei processi di disintermediazione”, e nel 2017 avvisava che “il sentimento prevalente nel Paese è quello del rancore”.
Inoltre si aggiunge la constatazione che non sia possibile sfuggire al peso e all’influenza che esercitano oggi i nuovi veicoli dell’immagine e del messaggio, compresi i processi di frammentazione individualistica che portano con sé. Per questo in molti si affrettano a dire che i partiti sono morti, finiti, che non ha più senso parlare di Articolo 49, senza peraltro valutare che una simile deriva porta inevitabilmente ad un restringimento degli spazi di democrazia, di pluralismo e di libertà. Questo modo di ragionare tuttavia stride e va in contraddizione quando di fronte vicende o passaggi che producono e inaspriscono la crisi sul piano economico e sociale, si fa appello alla coesione, al senso di responsabilità e all’impegno della comunità e del Paese. Un appello destinato a cadere nel vuoto se non ci sono i soggetti organizzati, riconosciuti e credibili in grado di interpretare la domanda di fiducia e gli interessi generali, assolutamente non sostituibili con operazioni di tipo populista e plebiscitario. Ecco che allora riproporre il tema dei partiti non è fuori luogo, è una esigenza primaria per il Paese. Ripartire dai valori di partecipazione, di democraticità e di trasparenza indicati dalla Costituzione nell’Articolo 49, è la prima condizione per una concreta rigenerazione del sistema politico; si tratta di pensare ad una legge sui partiti, non per i partiti ma per i cittadini, per renderli effettivamente “arbitri” del sistema politico e protagonisti delle scelte politiche.
Paolo Fontanelli